Come far fronte alla deflazione salariale (“il manifesto”, 18 ottobre 2010)
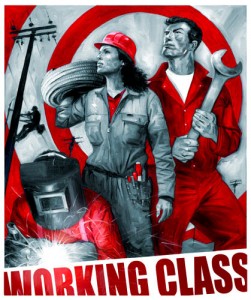 Nel corso degli ultimi decenni, in quasi tutto il mondo “sviluppato”, i redditi da lavoro dipendente hanno subito una riduzione di circa dieci punti percentuali di PIL a favore dei redditi da capitale e dei compensi professionali. L’aumento delle differenziazioni salariali e la diffusione del precariato hanno reso questa redistribuzione ancora più iniqua, moltiplicando la schiera dei senza salario e dei working poor, cioè di coloro che pur lavorando non riescono a raggiungere un reddito sufficiente per vivere decentemente. La crisi ha messo in luce – e continuerà a farlo per anni – la profondità di questa trasformazione.
Nel corso degli ultimi decenni, in quasi tutto il mondo “sviluppato”, i redditi da lavoro dipendente hanno subito una riduzione di circa dieci punti percentuali di PIL a favore dei redditi da capitale e dei compensi professionali. L’aumento delle differenziazioni salariali e la diffusione del precariato hanno reso questa redistribuzione ancora più iniqua, moltiplicando la schiera dei senza salario e dei working poor, cioè di coloro che pur lavorando non riescono a raggiungere un reddito sufficiente per vivere decentemente. La crisi ha messo in luce – e continuerà a farlo per anni – la profondità di questa trasformazione.
Infatti una parte rilevante dell’impoverimento delle classi lavoratrici era stato a lungo occultato con l’indebitamento (mutui, acquisti a rate, carte di credito, “prestiti d’onore”, usura) sul cui traffico è ingrassata la finanza internazionale con i suoi beneficiari, poi messi in salvo dalle misure anticrisi degli Stati.
Questo processo ha alterato profondamente la struttura industriale del mondo. La produzione dei beni di consumo più popolari ha progressivamente abbandonato i paesi già industrializzati, per trasformare la Cina e gran parte del Sudest asiatico in un’area manifatturiera al servizio del resto del mondo. In compenso è enormemente cresciuto, al servizio dei ceti politici, manageriali e professionali più ricchi o di autentici rentier, ceti ormai diffusi in tutti i paesi del mondo, un consumo opulento costituitosi in un vero e proprio comparto, denominato per l’appunto “lusso”, che riunisce indifferentemente gioielli, abbigliamento, calzature, pelletteria, arredamento, auto, imbarcazioni, aerei personali, resort turistici, ristoranti di grido, case e uffici principeschi, a cui è stato in larga parte delegato il compito di sostenere produzione e occupazione nei paesi di più antica industrializzazione: una sorta dei “keynesismo” di seconda generazione, in cui a sostenere la domanda globale non è più la spesa pubblica, ma quella dei ricchi.
Questa nuova allocazione delle risorse dà la misura dei guasti, in gran parte irreversibili, di un trentennio di liberismo. Perche l’aumento delle differenze nei redditi ha prodotto una redistribuzione settoriale e territoriale di produzioni e occupazione. A questo punto, difficilmente un aumento dei redditi popolari e della conseguente domanda di prodotti di consumo potrebbero avere effetti sostanziali su produzione e occupazione nei paesi di più antica industrializzazione; a meno di promuovere un processo di riterritorializzazione che, insieme alla rilocalizzazione degli impianti, investa contestualmente anche i modelli di consumo, gli stili di vita e la tipologia dei beni e dei servizi prodotti.
E’ altamente improbabile, comunque, che nei prossimi anni si possa assistere a un sostanziale recupero salariale, visti gli attuali rapporti di forza, che in tutto il mondo hanno messo alle corde il lavoro dipendente: grazie alla facilità con cui le produzioni possono essere delocalizzate in paesi con salari e protezioni ambientali più basse (e con un interventismo di Stato più elevato: vedi i sussidi che la Fiat ha ricevuto per trasferire le sue produzioni in Serbia); ma anche ai flussi migratori messi in moto dalla globalizzazione: sia quella dell’informazione e dei trasporti che quella della miseria. Caso mai è più probabile che continui il trend di deflazione salariale attuale.
Pertanto, senza sminuire l’importanza di mantenere aperto il fronte della lotta per il salario, la difesa delle condizioni di vita dei percettori di redditi bassi – o di nessun reddito; o di qualche forma di assistenza progressivamente erosa dallo strangolamento del welfare state – va probabilmente affrontata con altri mezzi: soprattutto attraverso una riconversione dei modelli di consumo che non riduca l’accesso ai beni di base irrinunciabili – o che addirittura lo migliori – limitando però gli esborsi monetari, i consumi superflui e gli sprechi.
E’ ovvio che di questo indirizzo possono e dovrebbero diventare un punto di riferimento tutti coloro che hanno conservato una maggiore possibilità di aggregazione, e che in moti casi sono anche i più direttamente colpiti: cioè gli operai delle fabbriche, in particolare di quelle investite dalla crisi o sul punto di esserlo. Ma le loro battaglie potranno avere esiti positivi se riusciranno a mettere in moto processi che coinvolgano anche altre fasce sociali.
Innanzitutto, trasformazioni in questa direzione potranno avere tanto più successo quanto più le entità associative troveranno sostegno, legittimazione e supporti tecnici ed economici da parte delle amministrazioni locali; e, naturalmente, quanto più riusciranno a sviluppare una interlocuzione, legata a precise convenienze, con una parte, almeno, dell’imprenditoria: a partire da quella impegnata nel sistema distributivo e nel comparto agricolo, ma senza trascurare l’artigianato – soprattutto quello di manutenzione – e, attraverso processi più mediati, anche la grande impresa di produzione e di servizio. Il meccanismo che accomuna i diversi processi è, o parte, dallo stesso problema: aggregare domanda.
Cominciando dalle cose più semplici: la nostra spesa quotidiana è composta in larga misura da imballaggi inutili e costosi (Coldiretti ha calcolato, per una serie di items di largo consumo, che spesso l’imballaggio assomma a un terzo del valore del prodotto e a volta lo supera: la “quarta settimana” di salario se ne va così direttamente nel cassonetto). Buone pratiche dal successo ormai consolidato dimostrano che molti di questi imballaggi, destinati a inquinare l’ambiente sotto forma di rifiuti e ad aggravare i bilanci dei Comuni e degli utenti che pagano i servizi di igiene urbana, possono essere eliminati con circuiti di vuoto a rendere o, in molti casi, con le vendite alla spina di prodotti sfusi. Dove gli enti locali si sono impegnati a promuovere questi sistemi, la loro diffusione e accettazione sono state più rapide. Lo stesso vale per gli altri prodotti ”usa e getta”, dalle stoviglie ai gadget ai pannolini.
Tra il campo e il negozio l’intermediazione dei prodotti freschi assorbe fino a quattro quinti del prezzo finale. I GAS (Gruppi di acquisto solidale) hanno dimostrato che in molti casi è possibile instaurare rapporti diretti con gli agricoltori, garantendo la qualità biologica del prodotto, un maggior ricavo per i produttori e un risparmio per i consumatori. Un vantaggio analogo – anche se con minori controlli – lo offrono i farm market (mercati aperti alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli). In entrambi i casi i Comuni possono giocare un ruolo centrale, innanzitutto nell’autorizzare, ma anche nel promuovere e sostenere, entrambi i processi.
Gli acquisti dei GAS, che sono una forma di auto-organizzazione dal basso, possono progressivamente estendersi a una gamma molto più ampia di prodotti, compresi molti beni durevoli: forse non tutte le intermediazioni possono essere facilmente bypassate; ma una convenzione con distributori disponibili, specie se promossa o garantita da un’amministrazione locale, può alleggerire notevolmente i ricarichi.
Da oltre un anno il mercato dell’energia è stato liberalizzato. Certo gli utenti non possono seguire giorno per giorno i corsi del kWh o del metano per scegliere di volta in volta il fornitore più economico. Ma quello che non può fare il singolo lo può fare per conto di tutti un’associazione; specie se a promuoverla o a garantirla è un Ente locale in grado di mettere a disposizione anche le competenze specifiche necessarie; magari ingaggiando o costituendo una ESCo (Energy Saving Company, cioè una società autorizzata a svolgere operazioni del genere). La stessa operazione si può fare contrattando direttamente anche le bollette telefoniche e di connessione con i provider informatici.
E veniamo agli interventi più pesanti: costi e consumi di riscaldamento e condizionamento (e persino quelli di illuminazione) possono venir contenuti drasticamente con interventi sulle apparecchiature, sull’impiantistica e sugli involucri degli edifici, tutte cose che oggi sono incentivate e che potrebbero fruire di un FTT (finanziamento tramite terzi) se eseguiti su larga scala. Una modalità che può azzerare i costi di installazione, ma a cui nessun privato ha la possibilità di accedere singolarmente. Un’iniziativa dell’Ente locale per promuovere l’accesso a questa opportunità in forma associata potrebbe sortire risultati rilevanti. Ovviamente il primo a mettere in ordine i propri edifici e impianti (anche per il suo effetto dimostrativo) dovrebbe essere l’Ente locale stesso, magari imponendo lo stesso intervento ai soggetti su cui può avere voce in capitolo: a partire dalle ex municipalizzate e soprattutto dagli ospedali, grandi consumatori di energia per riscaldamento, raffrescamento, forza motrice e sterilizzazione.
Questo discorso vale a maggior ragione per il ricorso alle fonti rinnovabili; solare termico per acqua sanitaria e preriscaldamento dei locali, fotovoltaico, ma anche eolico (dove ce ne sono le condizioni), minieolico e biogas nelle aziende agricole e negli stabilimenti sparsi sul territorio.
L’auto (acquisto, assicurazione, carburante, manutenzione, parcheggio e multe) divora da un terzo alla metà dei redditi bassi. Si dice che nessuno è disposto a staccarsi da questa sua protesi, e in parte è vero. Ma un servizio efficiente di mobilità di linea e personalizzata, promuovendo e organizzando car pooling, car sharing e trasporto a domanda, può permettere, soprattutto a chi l’auto propria o due auto in famiglia non può più permettersele, di farne a meno: con risparmi sostanziali.
Una grande risorsa è infine nascosta nel mercato dell’usato, oggi marginalizzato da un cumulo di divieti e dalle stigmate dell’esclusione. La quantità di beni durevoli avviati alla discarica o alla rottamazione senza essere né consunti né inutilizzabili è immensa. Qui il ruolo delle amministrazioni pubbliche può essere centrale. Sia per autorizzare raccolta, selezione, riabilitazione e commercio dei beni oggi destinati a ingrossare il flusso dei rifiuti (si pensi solo a quello che arriva nelle stazioni ecologiche), sia per legittimare e riconoscere un merito sociale a chi pratica, in qualsiasi posizione lungo la filiera del riuso, il recupero dei beni dismessi.
Strettamente legate alla estensione del riuso sono la capacità e la possibilità di riparare e di tenere in esercizio i beni durevoli che si guastano. Una capacità che può essere insegnata e diffusa: sia facendo riacquistare a ciascuno di noi, nei casi più semplici, una manualità a cui abbiamo rinunciato da tempo; sia creando le condizioni perché, nei casi più complessi, un esercito di artigiani sia disponibile a costi accettabili a prendersi cura dei beni da riparare; per permetterci di continuare a usarli, o per cederli a chi è disposto a riusarli.
E’ questo un grande bacino occupazionale, da tempo trascurato, ma che, oltre a ridurre gli sprechi, ha il vantaggio di riunire nella stessa persona manualità, attenzione (e persino amore) per le cose che ci circondano e competenze tecniche anche di altissimo livello: gli elementi essenziali del paradigma dell’”uomo artigiano” (Richard Sennet) in cui si concretizza la figura di lavoratore che ci porterà fuori, in positivo, dall’era fordista. Oltretutto, la presenza e l’accessibilità di reti diffuse e capillari di riparatori possono indurre una parte dell’apparato industriale a riconsiderare come fattori competitivi durata e riparabilità dei beni messi in commercio. Due caratteristiche oggi totalmente sacrificate all’alimentazione dei mercati di sostituzione; ma due formidabili fonti di risparmio per il consumatore.




